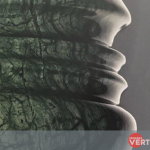24 maggio 1915. L’ora dell’Italia unita
“Beati quelli che più hanno. Perché più potranno dare, più potranno ardere. Beati quelli che hanno vent’anni, una mente casta, un corpo temprato, una madre animosa. […] Beati i giovani che sono affamati e assetati di gloria, perché saranno saziati […] Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte incoronata di Dante, la bellezza trionfale d’Italia”. Le parole, il tono riecheggiano il discorso della montagna evangelico, ma il Cristo che le recita, nel tripudio di patriottismo e furore romano di quel 5 maggio 1915, è il ben meno ortodosso dei poeti e degli artisti: quel Gabriele D’Annunzio che di lì a poco avrebbe vergato, questa volta con l’azione, altre memorabili pagine della sua “vita inimitabile” nei teatri della Grande guerra.
E’ l’Italia che “scende in campo”, o per meglio dire in trincea, quella che ricordiamo a 107 anni da quel fatale 24 maggio. O non sarebbe forse meglio scrivere ricordare «un’»Italia? La storia, è sufficiente l’esperienza prima ancora che la conoscenza delle sue categorie e leggi per rendersene conto, vive di cicli, dei vichiani “corsi e ricorsi”, ma tutti conservano nel tempo la loro unicità irripetibile. Ecco quindi che tentare paralleli tra cose, persone e nazioni del passato con le stesse del presente ci avvicina al gusto di un’avventura, quasi un diletto intellettuale figlio dell’ozio, alla fine della quale è alto il rischio di incappare in grossolane stramberie o ridicole forzature. E tutto questo perché? Per cercare di essere un pochino più all’altezza di coloro per i quali il destino scelse all’epoca la più crudele delle prove? Per tentare di accorciare, per mezzo di paragoni e confronti un poco azzardati, la distanza esistente tra noi poveri discendenti e i nonni e i bisnonni che sì, indubbiamente ricchi furono, ma di spirito e di coraggio? O forse ancora per sforzarci ogni tanto di ricordare a noi stessi, a motivo di autoconsolazione, che prima delle tristi pagine del presente ce ne furono di più luminose che scrivemmo nel passato, nemmeno poi così lontano?
Quel che è certo è che ci sentiamo oggi ben distanti da quella nazione che visse con euforia quelle “radiose giornate” del 1915. Il mondo ha compiuto giravolte e acrobazie di cui, come italiani, abbiamo più subìto che guidato gli effetti. E porgere per un attimo il pensiero ad avvenimenti che, senza retorica ma nemmeno pruriti autodenigratori, ci hanno visti protagonisti della storia mondiale, facendoci sentire per la prima volta “popolo”, sarebbe balsamo per gli spiriti molli e inebetiti dell’oggi. Nella pur drammatica esperienza di quel conflitto, l’Italia raggiunse un livello di compattezza e vigore che oggi ci parrebbe inverosimile. In un’epoca in cui carta d‘identità e passaporto sono ridotti a puro fatto amministrativo, mentre la stessa nozione di confini e di sovranità nazionale sono considerati alla stregua di fastidiosi orpelli non utili al moderno cittadino senza radici, quante possibilità esistono di interiorizzare appieno il significato politico (il completamento dell’unità nazionale dopo un processo cominciato nel 1848 con le guerre d’indipendenza), culturale (la formazione di un autentico senso d’appartenenza ad un’unica Patria, figlia diretta di quella “fratellanza d’arme” forgiata dal fango e dal sangue della trincea), morale (il sacrificio, la volontà, il trascendere sé stessi per donarsi ad una superiore causa, anche se non mancarono zone d’ombra) di quell’impresa?
Risulterà certo incomprensibile ai più sfuggire all’appiattimento minimalista che dai tempi dell’«inutile strage» di Benedetto XV ha portato a ingrossare i fiumi della retorica politicamente corretta con la quale si è involgarita l’analisi di quello spartiacque della storia italiana. Proprio per questo forse, azzardando una fulminea incursione nel romantico che sempre è presente sul grande palcoscenico della storia e nei suoi attori, non troveremmo miglior risposta che nella citazione dannunziana che abbiamo riportato in apertura. Si rivolgeva ai giovani il Vate, a quella fresca carne da “mandare al macello” e che invece dopo il 1918 avrebbe infiammato nuovamente un paese stremato ma per la prima volta capace di prendere in mano il proprio destino. Perché anche la Grande guerra ha avuto la sua meglio gioventù. Quei grandi fanciulli nati l’ultimo anno dell’Ottocento, l’ultima leva di 265mila italiani chiamati a resistere sul Piave, che cantavano con lo spirito innocente e temerario tipico dell’età e dell’epoca di sacrifici e che si rivelarono decisivi per la vittoria finale. Erano i “ragazzi del ‘99”. Nel 2007, a 107 primavere, si è spento l’ultimo di quei giovanissimi fanti, Giovanni Antonio Carta. Qualcuno dice che non fosse l’ultimo. Ma del resto questo, proprio come quei ragazzi, appartiene alla leggenda. E noi, che come italiani saremmo beati se ci ricordassimo degli eroi, non potremmo far altro che alimentarla.

Classe 1985, milanese di nascita e di crescita (il cognome, del resto, lo testimonia), spendo la vita in occupazioni perfettamente inutili e passioni meravigliosamente crudeli, di quelle, per intenderci, “che non ti portano da nessuna parte”. Appassionato studioso di storia, unica scienza capace di leggere il presente e predire il futuro, ha narrato le vite di grandi figure del passato accarezzate dal vento della pazzia attraverso il podcast La Festa dei Folli (che proseguirà). Per Pensiero Verticale, oltre che del coordinamento generale del progetto, cura i programmi web-radio I podcast di Pensiero Verticale e Zambracca.