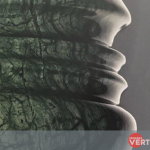A che ora è la fine del lavoro?
In un aneddoto apocrifo Henry Ford II, rivolgendosi a Walter Reuther, leader sindacale, gli chiede: “Walter, come convinci tutti quei robot a iscriversi al tuo sindacato?”. “Già, Henry, e tu come li convinci a comprare le tue macchine?”, è la risposta che riceve. Per quanto il tema del “futuro del lavoro” conti al suo attivo più titoli e convegni che seri e approfonditi progetti e investimenti non vi è dubbio circa la centralità strategica, dato il posto che esso occupa nelle nostre vite, di una questione la quale ormai non si limita ad emettere vagiti da lattante, ma vere e proprie grida d’avvertimento. Perché il lavoro, oltre che mezzo di realizzazione personale, è garanzia di relazioni, veicolo di mobilità e chiave di riscatto: è l’ingrediente più consistente della nostra pietanza identitaria, ed è quindi comprensibile che il minimo scossone venga percepito viceversa come un cataclisma biblico. E quindi che pensare dello spettro che si aggira oggi nel globo, l’imminente scomparsa del lavoro (umano)? Alla scomodità di dover pensare molti si concedono la comodità di un’opinione. Accerchiati da metafore di ogni sorta, le analisi sugli usi concreti delle tecnologie, oppure sulla possibilità di “aumentare” senza sostituire le capacità umane vengono quasi del tutto ignorate. Del resto, quanti non avranno orecchiato da più parti sordide cacofonie spacciate per orride minacce: i microchip sottocutanei per controllare i dipendenti, i robot che si sostituiranno ai nostri capi, l’ambiente di lavoro immateriale e permeabile dai “contorni” ridisegnati da uno smartphone, le intelligenze artificiali che scateneranno sanguinosi conflitti mondiali, la “carta di credito sociale” per stilare la classifica degli umani più affidabili, la miriade di mestieri soppiantati dai computer…Visioni (o paure) che si riaffacciano sul palcoscenico della storia economica in modo ciclico, come si può vedere in una significativa cartolina in cui compaiono giustapposte tre diverse copertine di “Der Spiegel”, il noto settimanale tedesco. La successione dei titoli scelti a corredo dell’immagine (un robot dai connotati umani rappresentato nell’atto di sbarazzarsi di un lavoratore umano) è rivelatrice: “Automazione in Germania, l’arrivo dei robot” (marzo 1964), “La rivoluzione dei computer: come il progresso causa disoccupazione” (aprile 1978), “Sei licenziato! Come computer e robot ci rubano il lavoro – e quali professioni saranno al sicuro” (settembre 2016). Dall’allarmismo al disastro, passando per la rabbia.
Oggi a che punto siamo? L’apocalisse, o meglio la “robocalisse”, è alle porte e ci sta pensando la pandemia in corso a favorire un aumento senza precedenti dell’automazione (fatevi un giro a Gardaland, gli umani sembrano gli appendiabiti delle macchine!), dal momento che “le macchine non si ammalano”, almeno stando a quanto sostenuto da alcuni commentatori. Sappiamo però quanto messaggi del genere fungano in realtà da arma retorica a giustificazione di interventi di deregolamentazione del mercato del lavoro, prendendo l’automazione come pretesto per far strage di oneri e responsabilità sulla pelle dei lavoratori. Questo non può far bene nemmeno all’imprenditore più spregiudicato, poiché in assenza di rapporti solidi e vincoli stabili il rapporto tra obiettivi dell’impresa e quelli della forza lavoro subisce pericolosi disallineamenti, quando invece proprio la partecipazione attiva dei lavoratori alla gestione aziendale costituirebbe la chiave di volta per aumentare soddisfazione, benessere e appagamento delle parti e sicura garanzia di un incremento di produttività. Forse a scomparire del tutto saranno alcuni lavori, ma non tante mansioni benché nessun mestiere sia intrinsecamente immune alla rivoluzione digitale. Un’ampia fetta di attività risulterà ancora difficile da meccanizzare, e in quanto ad abilità, estro, astrazione, improvvisazione, pensiero critico, giudizio analitico, intelligenza relazionale o sociale, doti di manipolazione e destrezza fisica l’uomo conserverà sempre proprie aree d’imbattibilità rispetto alla più perfetta delle macchine.
Tutto quanto sin qui espresso ha senso soltanto nella misura in cui l’uomo, e lui solo, saprà farsi trovare pronto dinanzi all’ennesima sfida epocale creata da lui stesso. L’uomo e la tecnica, ancora una volta. Attraverso essa l’uomo infatti mobilità il mondo, per dirla con Junger, dà cioè una forma al caos che lo circonda, pare proprio che costruisca una civiltà sconfiggendo le avversità naturali e infine edifica attorno a sé una realtà totalmente artificiale che chiama in causa inevitabilmente il suo essere. L’esistenza dell’uomo non può più fare a meno, in questa fase, della macchina, poiché essa è il suo prolungamento, ed è il lavoro appunto a divenire fulcro del suo vivere. Qui l’uomo faustiano centuplica la sua forza individuale, sospingendo la sua creazione sempre in avanti, compenetrando infine la sua esistenza con quella delle tecnologie: “questa passione faustiana ha trasformato l’immagine della superficie terrestre. […] L’anima ebbra vuol portarsi di là da spazio e tempo”, affresca Oswald Spengler nella sua opera principale. Eccola la civiltà faustiana. L’uomo europeo (o “occidentale”, secondo la chiacchierata generalizzazione), lo stesso con le gambe tremanti di terrore oggi dinanzi alla poderosa avanzata della tecnologia sul lavoro, è il bambino che con fervido entusiasmo ha abbracciato il destino di inesausta scoperta tecnico-scientifica , tracciando il solco di un’intera civiltà in perenne divenire.
E giunti sin qui, ritorna l’antico quesito: a che punto siamo? L’uomo europeo, che è faustiano, che è scopritore e conquistatore, pare aver smarrito la capacità di prendersi carico del proprio destino, avere cioè il coraggio di condurlo alle estreme conseguenze per preparare un nuovo inizio. La civiltà cammina, la civilizzazione procede spedita, si avverte stanchezza fisica ed intellettuale in un uomo che non si sente, non è, e non vuole più essere all’altezza del divenire e delle sue sfide. La trasformazione digitale può a ragione essere un alleato indispensabile, dalla fabbrica alla scrivania, dal magazzino all’ufficio, ma va messa alla prova sul terreno della convenienza sociale e politica e non solo su quello della convenienza economica. Ma non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive; esistono usi distorti e usi consapevoli delle invenzioni e delle innovazioni. Se, riprendendo il vecchio Spengler, “la tecnica è la tattica della vita”, ovvero “la forma intima del comportamento nella lotta” allora non è lo strumento il punto di partenza per cercare di immaginare rettamente il domani. “Non ha importanza la fabbricazione delle cose, ma il modo di comportarsi con esse; non l’arma , ma la lotta”, ci dice ancora dalle pagine de “L’uomo e la tecnica”. Gli uomini sanno (fare) più di quello che riescono a dire. Ed è riafferrando oggi il proprio destino di creatore il segreto per immaginare il nuovo lavoro che domani verrà.

Classe 1985, milanese di nascita e di crescita (il cognome, del resto, lo testimonia), spendo la vita in occupazioni perfettamente inutili e passioni meravigliosamente crudeli, di quelle, per intenderci, “che non ti portano da nessuna parte”. Appassionato studioso di storia, unica scienza capace di leggere il presente e predire il futuro, ha narrato le vite di grandi figure del passato accarezzate dal vento della pazzia attraverso il podcast La Festa dei Folli (che proseguirà). Per Pensiero Verticale, oltre che del coordinamento generale del progetto, cura i programmi web-radio I podcast di Pensiero Verticale e Zambracca.