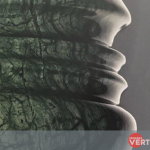Carlo Vichi, una storia d’amore (e di lavoro) tutta italiana
Lo incontrammo un gelido e fosco mattino di novembre, in un 2014 dal quale pare trascorsa un’era geologica e non appena che poco più di un lustro. Una domenica, a stabilimento chiuso ma quel giorno denso di presenze le più diverse: semplici curiosi, ex dipendenti Mivar, la sua creazione, in gran parte cittadini abbiatensi fieri e orgogliosi di vantare proprio nel cuore della propria comunità una storia di successo, così schiettamente e autenticamente italiana alla quale non tocca oggi che guardare con nostalgico rimpianto.
Ci colpì, sopra ogni altra cosa, la semplicità burbera di questo signore, attempato negli anni ma di nobile e giovane spirito, che è poi quello che permette agli uomini di costruire qualcosa di grande e duraturo nella vita e senza il quale la speranza è destinata a perire insieme allo sconforto di una vita dalle grigie tinte e dalla morale misera. La sua scrivania non è piazzata in una qualche lussuosa e distaccata sala della sede, ma proprio nel bel mezzo dello stabilimento, respirando lo stesso odore di lavoro, che è ossigeno puro, dei suoi dipendenti. “Al mio funerale non dovranno esserci le autorità”, aveva lasciato detto in alcune interviste, “la bara dovrà essere al centro dello stabilimento, poi ci sarà una bella festa”.

Fu una chiacchierata franca, sincera, durante la quale Vichi espose le problematiche affrontate nel corso della sua esperienza imprenditoriale, denunciando in particolare lo stato di quasi completo abbandono in cui versavano (e versano tutt’ora) le medie imprese italiane strozzate dalla tassazione esosa e dalla spietata concorrenza asiatica e americana. L’auspicio, più volte rimarcato, era la possibilità di costruire sin da subito una rete di solidarietà tra cittadinanza e mondo del lavoro, dalla quale, oltre ogni steccato e divisione del tutto anacronistici, far germogliare un nuovo “patto nazionale” in nome di un interesse superiore, sognato e ben delineato negli scritti dei corporativisti del primo Novecento.
E poi, il declino degli anni 2000, dovuto sia all’introduzione di nuove tecnologie come lo schermo piatto, sia alla diminuzione dei costi di produzione da parte dei concorrenti, potendo così praticare essi politiche parecchio aggressive sul mercato. Nel 2001 la prima cassa integrazione, negli anni successivi l’azienda inizia ad importare dall’estero alcuni componenti ma la crisi diviene irreversibile. Resta l’impianto, uno stabilimento modello che ha conosciuto storie, passaggi delicati, traversie e inevitabili cambiamenti che il vento del tempo porta con sè, lievemente scalfendo la materia ma non lo spirito che animò quella creazione tutta italiana. Carlo Vichi avrebbe offerto gratuitamente quello stabilimento a chiunque avesse voluto, alla condizione che venisse impiegata manodopera locale. Un invito rimasto lì. Proprio come il suo artefice, autentica testimonianza di vita pienamente vissuta.

Classe 1985, milanese di nascita e di crescita (il cognome, del resto, lo testimonia), spendo la vita in occupazioni perfettamente inutili e passioni meravigliosamente crudeli, di quelle, per intenderci, “che non ti portano da nessuna parte”. Appassionato studioso di storia, unica scienza capace di leggere il presente e predire il futuro, ha narrato le vite di grandi figure del passato accarezzate dal vento della pazzia attraverso il podcast La Festa dei Folli (che proseguirà). Per Pensiero Verticale, oltre che del coordinamento generale del progetto, cura i programmi web-radio I podcast di Pensiero Verticale e Zambracca.